Capital semántico, unicidad y responsabilidad en la era de la inteligencia artificial.

Leía hace un par de mañanas, mientras tomaba mi habitual cappuccino, una entrevista a Luciano Floridi.
Floridi no es un divulgador de ocasión, es uno de los filósofos contemporáneos más citados cuando hablamos de filosofía de la información, ética digital y tecnología; hoy trabaja en Yale, donde dirige un centro dedicado precisamente a pensar el impacto moral y cultural de lo digital, y ha investigado durante años cómo cambia nuestra vida cuando el entorno se vuelve “informacional”.
La entrevista gira alrededor de un concepto que él propone como clave para comprender qué hace al ser humano insustituible en la era de la inteligencia artificial: el capital semántico. El concepto me parece fantástico. Aunque, en mi humilde opinión, no se puede dejar solo. Hay que acompañarlo, tensarlo un poco, completarlo…
En la entrevista, cuando Floridi habla de capital semántico, se refiere —en esencia— a algo que muchos intuyen y pocos nombran bien: no a la información en sí, sino a la capacidad humana de darle sentido. No a la acumulación de datos, sino a su interpretación: contexto, criterio, lectura de lo real.
Es evidente que hoy la información está por todas partes. La diferencia ya no está en “tener acceso” a ella, sino en saber interpretarla, distinguirla, jerarquizarla, comprenderla. Ahí sitúa Floridi una de las grandes diferencias entre lo humano y lo puramente automatizable: en el significado, no en el dato. Eso es semántica en el sentido más profundo.
Hasta aquí, el análisis resulta especialmente lúcido.
Pero ese capital semántico, tal y como yo lo entiendo, no existe de forma abstracta. No es algo que se posea de manera uniforme. Depende radicalmente de quién eres, de tu sensibilidad, de tu historia, de cómo miras el mundo. Dos personas pueden leer lo mismo y no sacar lo mismo. No porque una entienda más y otra menos, sino porque cada ser humano es irrepetible, y esa irrepetibilidad transforma todo lo que entra en contacto con él.
Ahí, para mí, está la clave: no solo en el capital semántico, sino en la esencia de cada persona. En cómo cada uno procesa, interioriza y convierte lo que recibe en pensamiento propio. Sin esa dimensión, el concepto se queda incompleto.
En una vivencia, lo decisivo no es solo el contenido: es quién lo recibe.
Esto también explica por qué hay personas que, incluso rodeadas de estímulos culturales, no desarrollan mirada propia. Consumen, sí. A veces ni siquiera consumen: miran. Espectadores mudos que “no ven lo que leen”. Otras, en cambio, convierten lo que leen y lo que viven en pensamiento, en criterio, en opinión, en postura clara ante la vida y la realidad.
En otro pasaje de la entrevista, Floridi apunta a una cuestión que considero fundamental: cómo reaccionamos ante las máquinas y qué tipo de relación decidimos establecer con ellas. Habla del riesgo de convertirnos en usuarios pasivos y de la necesidad de pasar de “usar” a controlar el medio.
Más que una recomendación práctica, ahí hay una postura intelectual.
La tecnología no es solo herramienta: es entorno. Cuando el entorno decide por ti —lo que ves, lo que lees, lo que consideras urgente, lo que se premia, lo que se castiga con invisibilidad— el problema deja de ser técnico y se vuelve cultural.
Es como conducir un Ferrari o un coche completamente automatizado. En el Ferrari decides, cambias marchas, sientes la potencia, interactúas. En el otro caso, te llevan a ti.
Controlar el medio significa recuperar una soberanía básica: que la herramienta no determine tu manera de pensar, de actuar, de hacer.
Yo sin duda quiero seguir conduciendo mi Ferrari.
No se trata de demonizar la inteligencia artificial. Se trata de no entregarle las llaves del criterio, ni de la voz, ni de las sensaciones ni, por supuesto, del pensamiento.
Hay además un tercer ámbito que, aunque explicita en la entrevista, me parece inseparable de todo esto: la comunicación.
Hoy comunicamos mucho, sí. Pero gran parte de esa comunicación es reactiva, no participativa, no un intercambio. Un like, un emoji, una adhesión rápida. Eso no es diálogo. No es discurso. No es pensamiento compartido.
El lenguaje, entre personas, se empobrece cuando se vuelve pura reacción.
Y eso, además de ser prioritariamente la forma de comunicar hoy, tiene una consecuencia grave: perdemos la posibilidad de opinar, ser y estar. No porque esté prohibido hablar, sino porque se debilita el músculo que hace posible la opinión verdadera: lectura, comprensión, elaboración, contexto, la interacción, el pensamiento, el sentimiento.
Aquí hay una fractura clara. Algunas personas escribimos, hablamos, contextualizamos ideas, intentamos construir un hilo, no con falta de esfuerzo, por cierto, ni a costa de quedarnos al margen de la sociedad actual. Otras se limitan a reaccionar o, en los peores casos, atacar.
Reaccionar no es comunicar. No es participar en una conversación. Es simplemente emitir una señal.
La diferencia no es de estilo. Es de profundidad y, al final, de libertad intelectual.
Todo esto conecta directamente con una convicción que yo no negocio: leer es una forma de recuperar el pensamiento crítico. Comunicar es transmitirlo.
De ahí nace LEER PARA VER. Os lo he dicho varias veces ya. No para acumular información, sino para formar mirada. Leer para desarrollar criterio y después opinar. No como reflejo condicionado por el algoritmo de turno, sino como posición humana, propia, razonada.
Leer no como entretenimiento rápido, sino como formación interior.
Leer para ver; ver para poder decir algo que no sea mera repetición o porque nos lo indican algoritmos diseñados para manipular nuestro pensamiento, elecciones y vida.
Finalmente, llegamos a lo más delicado, el core de la entrevista: la inteligencia artificial.
Claro que la usamos, y está bien. Es un avance técnico comparable, en cierto sentido, al paso de la máquina de escribir al ordenador: reducción de tiempos, eficiencia, nuevas posibilidades. Recuerdo perfectamente cuando cambié una Olivetti eléctrica de mi padre por mi primer PC.
Pero hay una diferencia crucial. El ordenador no pensaba por ti.
La inteligencia artificial puede hacerlo, si tú se lo permites.
Por eso es importante decirlo con claridad: si no razonamos lo que leemos, si no indicamos con precisión lo que queremos, si no corregimos lo que la IA nos propone, si no afináramos el contenido… entonces la IA no sería nuestro instrumento. Nosotros estaríamos a su servicio, seríamos sus esclavos.
Eso no es progreso.
El progreso no consiste en delegar el pensamiento. Consiste en ampliar capacidades sin perder soberanía.
La inteligencia artificial puede ser una herramienta magnífica para la creatividad y el trabajo intelectual, pero solo si hay algo previo: pensamiento propio, criterio, responsabilidad sobre lo que se dice y cómo se dice.
Ahí vuelve el capital semántico: no como concepto bonito, sino como condición de posibilidad de una vida intelectual libre.
Hay un último punto que no quiero obviar.
Cuando incluso los discursos que alertan sobre la pérdida de singularidad adoptan un lenguaje estandarizado, reconocible, intercambiable, algo no termina de encajar. Es lo que veo constantemente en muchos artículos, post y entrevistas. Es síntoma cultural preocupante.
Porque defender el capital semántico implica también cuidar el lenguaje con el que se defiende. No para escribir bonito, sino porque el lenguaje es pensamiento. Si el lenguaje se vuelve cómodo, el pensamiento también lo hace.
Tecnología tenemos de sobra.
Más bien creo que nos falta participación. Capacidad de discernir, discurso. Nos falta la valentía para sostener ideas completas y no solo reacciones.
La era de la inteligencia artificial se decidirá en algo mucho más cotidiano y mucho más íntimo que en grandes entornos empresariales o de grandes magnitudes: en si seguimos pensando, leyendo, elaborando y diciendo “no, eso no es exactamente lo que quiero decir”.
Ahí empieza la libertad, y… curiosamente, también la verdadera modernidad.
…………….
Capitale semantico, unicità e responsabilità nell’era dell’intelligenza artificiale
Leggevo un paio di mattine fa, mentre prendevo il mio abituale cappuccino, un’intervista a Luciano Floridi.
Floridi non è un divulgatore occasionale: è uno dei filosofi contemporanei più citati quando si parla di filosofia dell’informazione, etica digitale e tecnologia. Oggi lavora a Yale, dove dirige un centro dedicato proprio a riflettere sull’impatto morale e culturale del digitale, e da anni studia come cambia la nostra vita quando l’ambiente diventa “informazionale”.
L’intervista ruota attorno a un concetto che lui propone come chiave per comprendere ciò che rende l’essere umano insostituibile nell’era dell’intelligenza artificiale: il capitale semantico. Il concetto mi sembra straordinario. Tuttavia, a mio avviso, non può essere lasciato da solo. Va accompagnato, messo sotto tensione, completato…
Nell’intervista, quando Floridi parla di capitale semantico, si riferisce — in sostanza — a qualcosa che molti intuiscono ma che pochi sanno nominare con precisione: non all’informazione in sé, bensì alla capacità umana di darle senso. Non all’accumulo di dati, ma alla loro interpretazione: contesto, criterio, lettura della realtà.
È evidente che oggi l’informazione è ovunque. La differenza non sta più nell’“avere accesso” ad essa, ma nel saperla interpretare, distinguere, gerarchizzare, comprendere. È qui che Floridi colloca una delle grandi differenze tra ciò che è umano e ciò che è puramente automatizzabile: nel significato, non nel dato. Questa è la semantica nel suo senso più profondo.
Fin qui, l’analisi è particolarmente lucida.
Ma questo capitale semantico, così come io lo intendo, non esiste in forma astratta. Non è qualcosa che si possiede in modo uniforme. Dipende radicalmente da chi sei, dalla tua sensibilità, dalla tua storia, dal tuo modo di guardare il mondo. Due persone possono leggere le stesse cose e trarne significati diversi. Non perché una capisca di più e l’altra di meno, ma perché ogni essere umano è irripetibile, e questa irripetibilità trasforma tutto ciò con cui entra in contatto.
Qui, per me, sta il punto centrale: non solo nel capitale semantico, ma nell’essenza di ogni persona. Nel modo in cui ciascuno elabora, interiorizza e trasforma ciò che riceve in pensiero proprio. Senza questa dimensione, il concetto resta incompleto.
In un’esperienza, ciò che conta non è solo il contenuto: è chi lo riceve.
Questo spiega anche perché esistono persone che, pur immerse in stimoli culturali, non sviluppano uno sguardo proprio. Consumano, sì. A volte nemmeno consumano: guardano. Spettatori muti che “non vedono ciò che leggono”. Altri, invece, trasformano ciò che leggono e ciò che vivono in pensiero, in criterio, in opinione, in una posizione chiara di fronte alla vita e alla realtà.
In un altro passaggio dell’intervista, Floridi affronta una questione che considero fondamentale: come reagiamo alle macchine e che tipo di relazione scegliamo di instaurare con esse. Parla del rischio di diventare utenti passivi e della necessità di passare dal semplice “usare” al controllare il mezzo.
Più che un consiglio pratico, questa è una posizione intellettuale.
La tecnologia non è solo uno strumento: è un ambiente. Quando è l’ambiente a decidere per te — cosa vedi, cosa leggi, cosa consideri urgente, cosa viene premiato e cosa viene reso invisibile — il problema smette di essere tecnico e diventa culturale.
È come guidare una Ferrari o un’auto completamente automatizzata. Con la Ferrari decidi tu, cambi marcia, senti la potenza, interagisci. Nell’altro caso, ti portano loro.
Controllare il mezzo significa recuperare una sovranità di base: fare in modo che lo strumento non determini il tuo modo di pensare, di agire, di fare.
Io, senza dubbio, voglio continuare a guidare la mia Ferrari.
Non si tratta di demonizzare l’intelligenza artificiale. Si tratta di non consegnarle le chiavi del criterio, della voce, delle sensazioni e, naturalmente, del pensiero.
C’è poi un terzo ambito che, sebbene non esplicitato nell’intervista, considero inseparabile da tutto questo: la comunicazione.
Oggi comunichiamo molto, sì. Ma gran parte di questa comunicazione è reattiva, non partecipativa, non uno scambio. Un like, un’emoji, un’adesione rapida. Questo non è dialogo. Non è discorso. Non è pensiero condiviso.
Il linguaggio, tra le persone, si impoverisce quando diventa pura reazione.
E questo, oltre a essere oggi la forma dominante di comunicazione, ha una conseguenza grave: perdiamo la possibilità di opinare, di essere e di stare nel mondo. Non perché sia vietato parlare, ma perché si indebolisce il muscolo che rende possibile un’opinione autentica: lettura, comprensione, elaborazione, contesto, interazione, pensiero, sentimento.
Qui emerge una frattura evidente. Alcune persone scrivono, parlano, contestualizzano le idee, cercano di costruire un filo — non senza sforzo, e certo non restando ai margini della società contemporanea. Altre si limitano a reagire o, nei casi peggiori, ad attaccare.
Reagire non è comunicare. Non è partecipare a una conversazione. È semplicemente emettere un segnale.
La differenza non è di stile. È di profondità e, in ultima analisi, di libertà intellettuale.
Tutto questo si collega direttamente a una convinzione su cui non transigo: leggere è un modo per recuperare il pensiero critico. Comunicare è trasmetterlo.
Da qui nasce LEER PARA VER. Ve l’ho detto più volte. Non per accumulare informazioni, ma per formare uno sguardo. Leggere per sviluppare criterio e poi esprimere un’opinione. Non come riflesso condizionato dall’algoritmo di turno, ma come posizione umana, propria, ragionata.
Leggere non come intrattenimento rapido, ma come formazione interiore.
Leggere per vedere; vedere per poter dire qualcosa che non sia mera ripetizione o perché ce lo suggeriscono algoritmi progettati per manipolare il nostro pensiero, le nostre scelte e la nostra vita.
Infine arriviamo al punto più delicato, il cuore dell’intervista: l’intelligenza artificiale.
Certo che la utilizziamo, ed è giusto farlo. È un progresso tecnico paragonabile, in un certo senso, al passaggio dalla macchina da scrivere al computer: riduzione dei tempi, efficienza, nuove possibilità. Ricordo perfettamente quando sostituii una Olivetti elettrica di mio padre con il mio primo PC.
Ma c’è una differenza cruciale.
Il computer non pensava al posto tuo.
L’intelligenza artificiale può farlo, se glielo permetti.
Per questo è importante dirlo con chiarezza: se non ragioniamo su ciò che leggiamo, se non indichiamo con precisione ciò che vogliamo, se non correggiamo ciò che l’IA ci propone, se non affiniamo il contenuto… allora l’IA non sarebbe il nostro strumento. Saremmo noi al suo servizio, suoi schiavi.
Questo non è progresso.
Il progresso non consiste nel delegare il pensiero. Consiste nell’ampliare le capacità senza perdere sovranità.
L’intelligenza artificiale può essere uno strumento straordinario per la creatività e il lavoro intellettuale, ma solo se esiste qualcosa di precedente: pensiero proprio, criterio, responsabilità rispetto a ciò che si dice e a come lo si dice.
Qui ritorna il capitale semantico: non come concetto affascinante, ma come condizione di possibilità di una vita intellettuale libera.
C’è un ultimo punto che non voglio tralasciare.
Quando persino i discorsi che mettono in guardia contro la perdita di singolarità adottano un linguaggio standardizzato, riconoscibile, intercambiabile, qualcosa non torna. È ciò che vedo costantemente in molti articoli, post e interviste. È un sintomo culturale preoccupante.
Perché difendere il capitale semantico significa anche prendersi cura del linguaggio con cui lo si difende. Non per scrivere “bene”, ma perché il linguaggio è pensiero. E quando il linguaggio diventa comodo, anche il pensiero lo diventa.
Di tecnologia ne abbiamo in abbondanza.
Quello che manca è la partecipazione. La capacità di discernere, il discorso. Ci manca il coraggio di sostenere idee complete e non solo reazioni.
L’era dell’intelligenza artificiale non si deciderà in grandi contesti aziendali o in scenari di grande scala. Si deciderà in qualcosa di molto più quotidiano e molto più intimo: nel continuare a pensare, leggere, elaborare e dire “no, questo non è esattamente ciò che voglio dire”.
È lì che comincia la libertà.
E, curiosamente, anche la vera modernità.
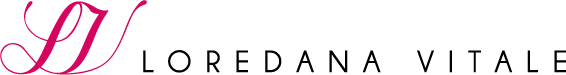

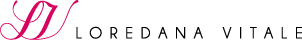
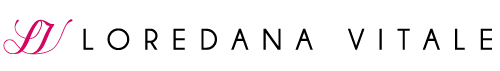
Sorry, the comment form is closed at this time.